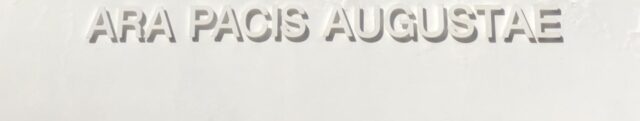L’Ara Pacis Augustae
Riemersi dal dislivello di circa sette metri nel quale si trova il Mausoleo lo sguardo e la curiosità corrono verso la grande “teca” che campeggia lì a pochi passi, l’Ara Pacis Augustae, edificata per volere dello stesso Imperatore in onore della dea Pax.

La costruzione originale sorgeva in un’area simbolica nei pressi del pomerium, in corrispondenza dell’odierna Piazza di San Lorenzo in Lucina, quella tra il Campo Marzio – utilizzato per gli addestramenti militari – e l’urbs laddove l’Imperatore perdeva il suo incarico di comandante delle milizie e riassumeva i poteri civili.
Era posizionata in modo tale che il grande obelisco che si trovava davanti all’entrata proiettasse la sua ombra durante l’equinozio di autunno il 23 settembre, giorno del compleanno di Augusto.
Le pareti di marmo erano decorate da fregi e bassorilievi che celebravano la grandezza dell’Imperatore e della sua dinastia, raffigurati in processioni secondo la linea di successione al trono, e quella di Roma e del mito della sua nascita.
Esposta alle frequenti inondazioni del Tevere e inglobata nella “sconsiderata” proliferazione urbana dei secoli successivi, solo verso la metà del 1800 si cominciò ad ipotizzare che i resti riaffioranti durante alcuni lavori appartenessero all’Ara anche se nel frattempo molti dei frammenti rinvenuti in precedenza erano già stati “acquisiti” e sono tuttora conservati nel Museo del Louvre e sulla facciata di Villa Medici a Roma.
Quando negli anni Trenta del ‘900 si procedette con i lavori di smantellamento e recupero dell’area adiacente a quella del Mausoleo, fu deciso che l’Ara fosse ricostruita nella zona attuale.
La “teca” che la ricopre ha subito diverse trasformazioni nel corso degli ultimi anni adeguandosi via via al nuovo assetto urbano ma rinnovandosi al tempo stesso allo scopo di voler preservare questo capolavoro di architettura ed espressione dell’arte romana.
Ciò che è rimasto invariato è la trascrizione, sulle pareti esterne, delle Res gestae divini augusto, il testamento politico lasciato dall’Imperatore.
Ed eccoci alla fine del nostro percorso e alla soluzione dell’enigma del titolo…
Alberto Biasi. Un tuffo nell’arcobaleno
Lo spazio sottostante dell’Ara, che ospita anche un auditorium, spesso viene utilizzato per mostre ed eventi. Attualmente è in corso una personale con alcune delle opere più significative del pittore Alberto Biasi, uno dei principali esponenti dell’arte cinetica italiana anche conosciuta come “optical art”.
È proprio questa la caratteristica delle sue opere realizzate tra il 1959 e il 2014: se ammirate da diverse angolazioni il sapiente gioco di tagli crea luci ed ombre e i colori cangianti che ne derivano ne annullano la staticità inventando un movimento tutto da scoprire.
Il titolo della mostra, fino al 30 aprile, rende omaggio ai lavori di questo artista che ha esposto nei principali musei in Italia e nel mondo, partendo da Padova – dove è nato nel 1937 – per arrivare alla GNAM di Roma e al MOMA di New York, per citarne alcuni.

Come in un Arcobaleno, tra Trame, Torsioni, Politipi e Assemblaggi, il caleidoscopio di colori che si sviluppa da ognuna delle opere esposte è messo ancora più in risalto dal candore dei marmi della struttura circostante .
E la loro modernità viene esaltata dall’antichità del luogo in uno scambio reciproco, quasi a rievocare i colori originali dei fregi, dove l’antico e il moderno si integrano perfettamente e si fondono fino a diventare un unicum senza tempo.